Pubblichiamo l’intervento, in una mail-list professionale, di un collega frastornato da certa “ingenua” protervia di neo-formati counselor.
Un’impiegata (la chiamerò M) mi invita a pranzo alla sua mensa aziendale. Mi è stata presentata da amici comuni. Accetto l’invito per cortesia nei loro confronti, per curiosità, per modificare la routine lavorativa.
Dunque M ha circa 50 anni, due figli ormai adolescenti, non credo sia laureata e ha un marito dirigente di altissimo livello. Non è una famiglia toccata dalla crisi economica, ma M sente il bisogno di nuovi stimoli visto che i figli sono ormai indipendenti.
M sta per concludere un corso in counseling. Afferma: “ho fatto crescere due figli, credo di essere stata una buona madre, perché non posso fare anche io la terapeuta?” Siccome un terapeuta assume una funzione genitoriale lei si sente legittimata ad esserlo per il fatto che è madre. Durante l’incontro mi considera un collega alla pari (il suo stato mentale è: io e te siamo due operatori del disagio mentale, anche se io non me ne occupo). La cosa mi irrita e le lancio messaggi che sottolineano la nostra differenza: sono 30 anni che sono laureato, sarò pure uno psicologo non eccelso, ma ho la mia esperienza, le specializzazioni, le pubblicazioni.
E’ presa dal sacro fuoco di guarire la gente: “non puoi immaginare –afferma- quanti colleghi io segua in questa azienda, qui c’è un grande malessere”. Intuisco che sono chiacchierate al bar o nei corridoi. Ad un certo punto mi dice: “scusa, ma perché sei stato così…… da averci messo tanti anni per arrivare al risultato a cui io sono arrivata in pochi anni?” Forse non trova la parola o forse non vuole ferirmi perché credo che questa sarebbe “coglione”. Confesso che ho sentito il desiderio di strangolarla, ma dal suo punto di vista non aveva tutti i torti. M mi ha voluto vedere perché vorrebbe proporre alla sua azienda, appena conseguito il diploma, un Centro counseling rivolto ai lavoratori e voleva confrontarsi “con un collega”, insomma vuole istituzionalizzare quello che fa ora.
Le dico che il suo ruolo aziendale di impiegata (passato e presente) mal si concilia con l’intervento che lei ha in mente (però a ripensarci ora, quanti psicoterapeuti frequentano i loro pazienti fuori dal setting terapeutico?) e che la sua azienda forse può essere non interessata a prendersi cura del disagio dei lavoratori, ad esempio perché è funzionale al loro allontanamento o per la sua cultura organizzativa. Non la convinco. Mi dice che sono privo di ottimismo e rassegnato. Per lei esiste solo “chi sta male” e “chi guarisce”.
Sento di nuovo il desiderio di prima, ma poi mi chiedo se non possa riuscire nel suo intento di farsi riconoscere il suo progetto, magari utilizzando le influenti amicizie del marito.
Esco dall’azienda e penso che forse da strangolare sarebbero i colleghi psicologi che stanno formando tali figure professionali, che stanno supportando l’onnipotenza di alcuni, senza spirito etico, solo per sopravvivere economicamente (immagino la loro replica molto italiana: “tengo famiglia”). Alle prossime elezioni ordinistiche queste scuole faranno molte pressioni sui loro attuali ed ex allievi perché perduri questa situazione. E molti colleghi seguiranno le loro indicazioni di voto nella speranza di strappare qualche ora di docenza.
Penso anche ai nostri committenti: già non hanno capito la differenza tra psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista, psichiatra e ora li confondiamo con il counseling!
Si, M ha ragione: sono privo di ottimismo e rassegnato.
Messaggio firmato







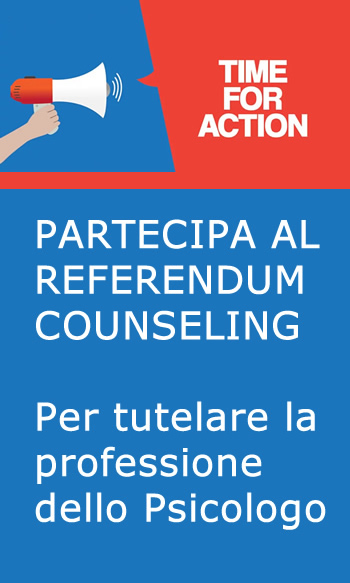






Trackbacks/Pingbacks