Questo articolo racconta una storia pessima, ma istruttiva. Di recente ho dovuto restituire un acconto a una cliente. L’ho fatto con sorpresa, rabbia, rammarico, incredulità.
Gli psicologi che leggeranno si stupiranno dell’aspetto soggettivo e coglieranno la gravità soggettiva, la malattia di chi non è in grado di vivere l’esperienza della gratitudine.
Gli avvocati ci vedranno il raggiro di una cliente che è riuscita a non pagare la parcella per una consulenza portata a termine.
A me quello che più preoccupa è che la legge italiana, così come è costruita e applicata, nega un’importante tutela a chi ne ha più bisogno. Ecco la storia.
Maria si presenta in studio da me quasi due anni fa. Era una donna disperata.
Maria era una vittima di quella “violenza economica” che, dopo una vita da moglie e madre a seguito di una separazione conflittuale trasforma la vita rendendola difficile. Lasciata ad affrontare senza risorse la sua battaglia legale è stato facile per il marito e i suoi consulenti convincere un giudice che Maria soffriva di “personalità schizotipica”, praticamente l’anticamera della follia. Una diagnosi sbagliata, che, anche se non dovrebbe succedere, di fatto era costata a Maria la possibilità di vedere liberamente suo figlio Gianluca, che aveva sette anni quando è stato prelevato a scuola dalle assistenti sociali come in un film e portato via da lei, al “sicuro” a casa del padre. Affidamento esclusivo, rarissimo di questi tempi, come nei casi peggiori, quelli di violenza o incuria grave. Certamente il fatto di essersi presentata nel corso di questa prima valutazione senza l’ausilio di un proprio consulente di parte aveva ampiamente contribuito al disastro che avevo di fronte. Non solo mi dispiaceva, ma trovavo ingiusto il destino di questa donna, deciso da un errore.
Maria mi ha chiesto aiuto chiedendomi di farle da consulente di parte nel corso di una seconda valutazione che i suoi legali avevano ottenuto dal tribunale. Il suo caso sembrava tecnicamente risolvibile.
Ho accettato di fare con Maria un accordo impossibile, poche decine di euro al mese che spesso lei non ha avuto nemmeno la possibilità di darmi a fronte di un lavoro faticosissimo anche a causa dei consulenti del padre che non risparmiavano scorrettezze di ogni genere, stratagemmi e attacchi personali a me e alla consulente nominata dal tribunale. Il tutto durerà quasi un anno e mezzo ma si concludeva con la correzione della diagnosi e la dimostrazione che non si trattava di una mamma così incompetente nel suo ruolo da richiedere di vedere il figlio sotto la rigida sorveglianza degli educatori. Una storia a lieto fine, ma con un epilogo. Maria smette infatti di pagare il suo importo dilazionato nell’istante stesso in cui consegno la mia relazione e, tempo dopo mi chiede, contro il parere dei suoi stessi legali, la restituzione di tutto ciò che ha versato. 1.200 euro che ho dovuto pagare nonostante la chiara evidenza di un contratto controfirmato e da me interamente onorato.
Nonostante tutto, Maria decide di fare qualcosa che la legge le consente di fare. Perché lo fa?
Forse per il lugubre godimento che viene da un simulacro di vittoria per chi è abituato a vivere secondo una legge crudele di sopravvivenza, mors tua vita mea. O forse semplicemente lo fa perché lo può fare, perché non è in grado provare gratitudine e di conseguenza sperimentare il desiderio di retribuire, nel suo senso etimologico di restituzione perché ha di fronte a sé ha un panorama desolante, degradato, perché sente il diritto alla rivalsa per una povertà che non è reale ma un buco nero profondo, interiore.
Ma come è possibile che il livello del diritto colluda con la malattia, con la desertificazione interiore, con l’individualismo autarchico?
La Costituzionale esprime un principio corretto: le persone in difficoltà economica hanno diritto alla difesa e a essere rappresentate in giudizio in modo identico a chiunque altro, grazie all’istituto del “gratuito patrocinio”. Per questo gli onorari degli avvocati e anche del consulente tecnico “vengono prenotati a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario” (l’ordinanza Corte Cost.le n. 12, 6/2/2013). Teoricamente sembrerebbe tutto chiaro: lo Stato interviene laddove vi sia una difficoltà economica, per garantire un diritto. Lo dice la costituzione, lo ribadisce la legge, lo conferma la giurisprudenza. Eppure, proprio qui dove il diritto diventa concreto interviene il paradosso. L’istituto del gratuito patrocinio infatti è reale soltanto limitatamente alla difesa legale.
Quando invece il problema è relazionale e riguarda la famiglia, un’accusa di violenza o il fantasma della follia allora è la dialettica tra CTU e CTP a governare il gioco, rispecchiando quella del giudice, dell’accusa e della difesa. In questi casi il diritto a usufruire di un proprio consulente di parte è chiaro. Nessuno nega il principio per il quale in caso di difficoltà economica si possa “prenotare a debito” dello Stato la parcella del proprio consulente attraverso un decreto del giudice.
Ma ecco lo straordinario salto logico, l’impossibile che diviene realtà. Già, poiché il Direttore Generale del Ministero della Giustizia con la circolare 8 del 2016 spiega qualcosa di molto folkloristico, ovvero che il riconoscimento di un debito da parte dello Stato italiano è un diritto ma… non significa che lo Stato lo pagherà.
Ecco il brano, che merita di essere citato letteralmente:
“(la Corte Costituzionale, ndr) non ha fatto altro che ricordare che la liquidazione segue necessariamente la richiesta di prenotazione a debito da parte del consulente, ma non ha certo introdotto un automatismo tra la prenotazione a debito e la liquidazione, che è (e dunque rimane) meramente eventuale”.
E infatti, prosegue la stessa circolare
“si definisce ‘prenotazione a debito’ l’annotazione “a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento.”.
I giudici di merito spesso si rifiutano perfino di emettere decreti che sono lettera morta. Ma in questa realtà kafkiana, in questo teatro dell’assurdo, un secondo pezzo di un puzzle che fattivamente nega un diritto.
Perché se Maria decidesse di cavarsela da sola con le poche entrate di cui usufruisce con l’aiuto di un consulente che volesse aiutarla accontentandosi di un rimborso spese, questo sarebbe considerato illegittimo e il contratto stipulato con lei sarebbe in ogni caso nullo. Anche se onorato. Gli eventuali importi ricevuti andrebbero restituiti.
Già perché nel cristallino universo delle norme astratte il DPR 115 del 2002 sulle spese di giustizia tutela il soggetto in difficoltà economica escludendo che il proprio legale, o consulente pretenda una qualsiasi integrazione all’importo (fisso e in verità abbastanza contenuto) che deve obbligatoriamente pervenirgli in toto dall’erario o dalla parte soccombente del procedimento:
“1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario è nullo. 3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare”.
Quando nello studio del professionista si presenta una qualunque Maria in situazione di grave difficoltà e di debolezza ecco, allora lo psicologo o lo psichiatra di cui sopra non potrebbe -non dovrebbe- fare niente, perché lo Stato ha fatto in modo grazie alla più assurda dell’ipocrisia di legargli entrambe le mani. Chi non lo sa, e in molti colleghi non lo sanno, affronta il rischio. Un importante avvocato mi ha segnalato che esistono siti internet che consigliano ai clienti di pagare e poi di eccepire al termine dell’incarico la nullità del contratto, facendosi restituire eventuali acconti, ma essendosi garantiti il lavoro di consulenti di propria scelta e talora anche di grande competenza.
L’impatto più grave è però sempre e comunque verso chi usufruisce del gratuito patrocinio. Lo Stato in questo caso ipocrita, dai giusti princìpi ma dal braccio corto, sottrae, priva, toglie, scippa la possibilità proprio della persona in maggiore difficoltà di essere tutelata.
Per lo lo psicologo o psichiatra, che si occupi di diritto di famiglia e che voglia aiutare una persona in difficoltà economiche, egli può solo prenotare il suo debito “a futura memoria” ma già sa che non verrà pagato dallo Stato se non in casi “meramente eventuali”: quali? Forse qui un dialogo tra gli Ordini e i Tribunali potrebbe fare qualcosa? Molto?
Sta di fatto che il combinato normativo prevede la sostanziale totale gratuità della prestazione.
O -fatalmente- la rinuncia a seguire il caso. Il risultato è intuibile, semplice quanto tragico.








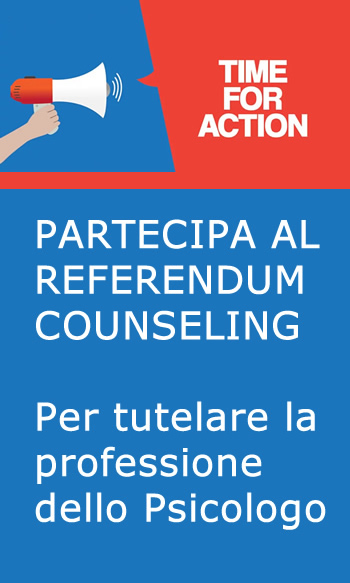






In realtà a mio parere non è proprio così. Nel senso che lo stato non può subordinare incondizionatamente (E DIFATTI NON SUBORDINA INCONDIZIONATAMENTE) il pagamento del ctu o del ctp dell’ammesso al pss al recupero delle somme prenotate o anticipate a favore della parte “povera”. IN sostanza prenotando a domanda il pagamento delle spese e dell’onorario il consulente ha diritto alla liquidazione e non deve certamente attendere all’infinito. La normativa prevede solo che debba concludersi la procedura di riscossione incoata da equitalia neiconfronti della parte ricca condannata o, in seconda battuta e a certe condizioni, di quella ammessa al pss. Ilhe in sostanza vuol dire, allo stato, attendere anni. Campa cavallo… lavoro da anni nel settore del recupero crediti per conto di un ufficio giudiziario… La sua lettera potrebbe costituire iuno spunto per affrontare e risolvere la seria problematica, problematica che si ha l’obbligo di risolvere fugando dubbi e errate interpretazioni. Ne va del diritto sostanziale e sacrosanto alla difesa, riinosciuto dalla nostra Costituzione a tutti.