La vicenda di Meloni e Letta che dissertano di ‘devianze giovanili’ poteva finire lì.
Si era già capito che nessuno dei due aveva idee sensate in merito.
Anzi, si era capito che entrambi partivano dallo stesso erroneo presupposto che ‘devianza’ sia un’etichetta oggettiva che si può applicare ai fenomeni sociali per distinguere quelli ‘devianti’ da quelli ‘non devianti’.
Le due posizioni cambiano solo nell’idea di cosa farne, dei ‘devianti’.
Giorgia Meloni è pulitissima: vanno corretti.
Enrico Letta, forse per provare a differenziarsi, tenta una goffa celebrazione con quel ‘Viva le devianze’ che mostra lo stesso identico pregiudizio: anche per lui esistono dei ‘devianti’.
Nessuno dei due pare orientarsi nelle insidie dei processi di etichettamento, in cui classificazioni di tipo etnico, razziale, morale, comportamentale servono alle lotte di potere fra gruppi sociali.
Il costrutto di ‘devianza’ descrive proprio i processi di conflitto fra gruppi sociali in cui uno – di solito quello che detiene più potere -etichetta l’altro come ‘deviante’ da una norma con lo scopo di assimilarlo per correzione o segregarlo in quanto dannoso e non correggibile.
Il costrutto di ‘devianza’ non è nato per etichettare fenomeni sociali come farebbe un naturalista con le foglie.
Il tema non è quindi cosa contiene la blacklist, quali fenomeni includere.
Il tema è di avere il coraggio (o la cultura) di non usare il costrutto di ‘devianza’ per classificare le condizioni umane.
L’intelligenza di capire che il costrutto ‘devianza’ descrive dei conflitti tra gruppi sociali diversi, non delle condizioni umane.
Ma purtroppo, e qui bisogna fare autocritica, non lo capiamo nemmeno noi psicologi.
L’ORDINE LOMBARDIA E IL CNOP
Cercando maldestramente di fare chiarezza, il Consiglio Nazionale condivide un post dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia sulle ‘devianze giovanili’.
Il post originale dell’Ordine Lombardia recita:
“Il tema delle devianze giovanili dovrebbe essere centrale nelle agende di lavoro dei politici in modo da favorire la tutela della salute dei giovani, promuovere resilienza e attenuare le differenze sociali”.
Qui l’Ordine cade nello stesso errore di Meloni e Letta: parte dal presupposto che le ‘devianze giovanili’ esistano.
Cioè che esistano come oggetti naturali, classificabili.
Che se ne possa fare, ancora una volta, una lista.
E, anche, che questa faccenda della ‘devianza’ riguardi i ‘giovani’.
È solo sul ‘cosa farne’ che l’Ordine si differenzia, adottando una posizione di indulgente paternalismo in cui si vuole ‘tutelare la salute dei giovani’ (sono dunque malati?), ‘promuovere la resilienza’ (e che vuol dire?), ‘attenuare le differenze sociali’ (omologando i ‘devianti’ dopo averli etichettati come tali?).
E allora sarebbe da chiedere all’Ordine Psicologi Lombardia di esplicitarci questa lista di ‘devianze giovanili’.
Ed è qui che cadrebbe il palco.
Perché qualunque elenco sarebbe un elenco a sentimento, privo di alcuna oggettività o scientificità e fondato semplicemente su pregiudizi sociali verso persone, gruppi o comportamenti.
A questa richiesta si dovrebbe solo rispondere che ‘devianza’ è un’etichetta usata per agire conflitti di potere fra gruppi sociali.
Che il costrutto ‘devianza’ indica un fenomeno di campo, una partita fra gruppi sociali che si contendono un potere.
Un conflitto in cui nessuno dei due è portatore di un qualche problema, ma entrambi giocando la partita del potere usano anche l’arma di qualificare [negativamente] le caratteristiche dell’altro.
Ma nulla di tutto questo filtra dal post dell’Ordine Lombardia, che invece sposa l’idea che alcuni fenomeni siano in sé delle ‘devianze’ e coniugandole al ‘giovanile’ completa un’operazione di doppio stigma.
Ma si poteva fare peggio. E l’Ordine Lombardia ci è riuscito.
Nel maldestro tentativo di spiegare cosa sia una devianza, l’Ordine chiama in causa la rarità statistica.
Con una posizione fra il pilatesco e l’accademico, viene saltato a piè pari un secolo di antropologia, di sociologia e di lotta alle discriminazioni.
Tutto diventa una questione di frequenza.
Dubito però che l’Ordine, chiamato a rispondere, elencherebbe fra le ‘devianze giovanili’ rarità statistiche come le manifestazioni comportamentali dello spettro autistico, particolari abilità matematiche o gli sport estremi.
Più probabilmente fornirebbe, come tutti, il solito elenco paternalistico e fondato sulla colpa: droga, sesso promiscuo, bullismo, baby gang e tutto il corredo dei cattivi.
Che poi siano da condannare, correggere, integrare o curare, poco importa. Sempre cattivi sono.
DALLA DEVIANZA ALLA CITTADINANZA
La questione della devianza è del tutto analoga alla questione di classificare le etnie, operazione priva di base scientifica e spesso operata per segregare gruppi sociali allo scopo di limitarne i diritti di cittadinanza.
Qui stiamo assistendo ad processo simile: un gruppo che ritiene di essere ‘normale’ individua dei gruppi che etichetta come ‘devianti’.
In particolare, trattandosi di devianze ‘giovanili’, qui sono i ‘giovani’ (qualunque cosa siano) ad essere derubricati, in tempo di elezioni politiche, da cittadini a problema sociale oggetto di attenzione dei ‘veri’ cittadini.
Un’operazione che fonda le sue radici nella mentalità gerontocratica per cui il ‘giovane’ ha qualcosa che non va a prescindere, in quanto ‘giovane’.
Se noi psicologi avvalliamo l’idea che esistano delle ‘devianze giovanili’, stiamo avallando un’operazione di classificazione discriminatoria e classista che non è scientifica, ma sociale e politica.
Il tema di fondo è sempre quello di segregare gruppi di persone in base a comportamenti o caratteristiche che un gruppo di potere definisce anormali.
Fino agli anni 70 lo facevamo con gli omosessuali, per dire: erano ‘deviati’, o ‘invertiti’.
Ora rischiamo di farlo con altri gruppi sociali.
Ad esempio i consumatori di sostanze. I bulli. I profughi. I criminali. Anoressici, obesi, alcolisti, autolesionisti.
Ciascuno compila la propria lista di ‘devianti’.
La Meloni ha una lista più lunga.
L’Ordine Psicologi magari avrà una lista più corta e più ‘politicamente corretta’.
Ma l’operazione di base è la stessa ed è sbagliata.
Occorre proprio uscire dalla logica asimmetrica in cui un gruppo sociale si arroga il potere di classificarne un altro.
Mentre finché usiamo il concetto di ‘devianza’ come etichetta per i fenomeni, la dinamica è che io decido per te chi sei (etichetta), cosa senti (hai un problema), e cosa devi fare (ti serve una cura che io scelgo per te).
E in questo modo tu resti sempre un po’ meno cittadino di me.








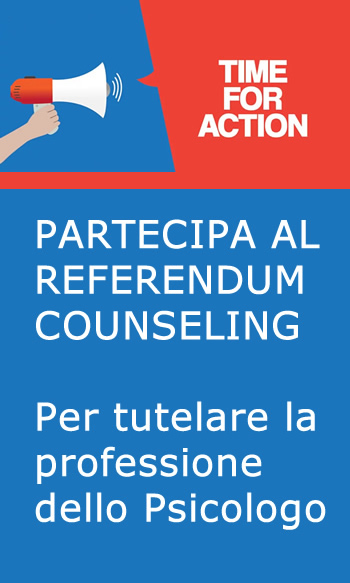






Ho letto con piacere l’articolo di Zanon sul tema devianze in cui inciampa opl e mi permetto di integrare un elemento, che può aiutare a comprendere non tanto la devianza, ma la deriva in cui sta scivolando questa realtà di rappresentanza professionale.
Qualche tempo addietro, una collega appartenente al “comitato scientifico” posta un video sul canale telegram di opl e credo anche su Facebook (non sono sui social), in cui asserisce l’importanza, oggigiorno, di fare uso di etichette. Un video in cui regna l’ambiguità circa i suoi presunti fondamenti scientifici (non citati, ma solo magnanimante inferibili dalle credenziali offerte in presentazione “membro del comitato scientifico”… di un ordine professionale, sicché, una sicurezza…oppure no?)
Ammetto di essermi sentita alquanto confusa di fronte a quel breve, lapidario video, rivolto agli iscritti (perché?).
Le etichette offrono un reale quid aggiuntivo al mondo in cui viviamo?
Sicuramente sì, se adottiamo il nostro spirito del tempo, che poggia sull’assunto dell’inclusivita’, termine oggi malamente abusato anche per pubblicizzare bevande, ma che etimologicamente deriva dal verbo latino claudere: Chiudere. Includere significa, in buona sostanza, “chiudere dentro”. E nella logica del “chiudere dentro”, dell’incasellare, l’uso dell’etichetta è un’azione alquanto spontanea e consequenziale.
Etichetta, invece, è un termine moderno, che probabilmente ha origine nell’inglese ticket e fa riferimento all’uso di recapitare un biglietto alle persone invitate a un evento mondano per loro assegnare il posto che devono occupare, anche in termini di comportamento prescritto ed adesione alle regole della polite society. E qui arriviamo per logica allo scivolone della devianza, dei cattivi da correggere etc etc…
Ma davvero le persone di cui noi ci occupiamo necessitano di (ulteriori) etichette, sapendo che esse limitano, non aprono, “chiudono dentro” (in-cludono)? Kierkegard forse ne sa qualcosa…
E siamo sicuri che l’abuso di etichette sia d’aiuto al processo di emancipazione, individuazione, liberazione dell’individuo? Oppure rischiamo di andare alla deriva in un mondo di vincoli, divisioni, purtroppo anche visioni faziose, partigiane, ovviamente politiche?
Noi psicologi ben sappiamo (o dovremmo sapere) che la costruzione delle categorie mentali sono mediate dalla cultura. Basti pensare alla nosografia psichiatrica e di come sia mutata in meno di vent’anni… Se l’adulto insegnerà al bambino la differenza tra una persona dalla pelle bianca e una scura, allora registrerà questa distinzione categoriale, prima non osservata. Il linguaggio crea il mondo.
E noi dove stiamo? Intendo come professionisti?
Siamo promotori ciechi di adesione agli estremismi della cultura del tempo o di emancipazione degli individui da essa? Vogliamo che gli individui si confrontino con un mondo incasellato in categorie/sottocategorie o desideriamo che essi abbiamo modo di scoprire la propria unicità? Vogliamo recapitare agli individui il loro ticket per partecipare alla polite society oppure vogliamo che trovino loro stessi? Unicità è antitesi del calderone dell’etichetta in cui vogliamo gettare le persone. Ogni persona, come diceva il buon vecchio professor Guidolin, è unica e irripetibile. E le etichette sono più comode sul dorso dei fascicoli amministrativi che sulla fronte delle persone. Il singolo individuo non potrà mai ripetersi nella storia infinita del tempo (neppure se clonato) e la sua realizzazione in quanto persona (e non come appartenente a una categoria generata da un’etichetta) è di gran lunga più importante dell’etichetta stessa. Oppure no? Colleghi… battete un colpo.